Un viaggio alla scoperta della natura, la storia, la cultura e le tradizioni dell’Afghanistan.
Si può facilmente supporre che prima del 2001 ben pochi italiani conoscessero qualcosa di più dell’Afghanistan oltre il nome; un’idea – molto vaga – della sua collocazione geografica e dei confini territoriali, qualche ricordo di un’invasione sovietica (chi per età poteva rammentarla) e immagini di figure femminili rinchiuse in un burqa, un fitto reticolato di stoffa come finestra sul mondo. Si può altrettanto facilmente supporre che oggi gli italiani ne sappiano appena poco di più, nonostante i quasi dieci anni di guerra trascorsi, e che le scarse informazioni comprendano gli aspetti peggiori: talebani, mederse, kamikaze, signori della guerra, coltivazione di oppio e traffico di droga, sharia, ancora burqa. Poco male, si potrebbe cinicamente concludere: meno si conosce il ‘nemico’ e meglio è. Può in tal modo continuare a essere ‘l’altro’, il diverso, il barbaro a cui portare democrazia, diritti umani e cultura.
Cofanetto V, dal tesoro di begram, avorio, I sec
Uno dei tesori più straordinari mai ritrovati – da un punto di vista materiale ma ancor più per l’aspetto culturale – è il tesoro della Bactriana, rinvenuto nel nord dell’Afghanistan, quasi al confine con il Turkmenistan, nella località di Tillya Tepe (che in uzbeco significa la Collina dell’Oro), nella regione che i greci chiamavano Bactriana – dalla città di Bactria, oggi Balkh, uno snodo importante sulla Via della seta. Scoperto nel 1978 da Sarianidi, un archeologo di origine greca nato in Uzbekistan, le sei tombe hanno restituito 26mila pezzi d’oro, d’argento e d’avorio, ornati di pietre semipreziose. Sarianidi ritiene che le tombe risalgano all’epoca degli imperatori cinesi Han (206 a.C. – 220 d.C.); apparterebbero agli yue-che, pastori nomadi centroasiatici, originari dell’alto bacino del Fiume Giallo. Gli archeologi non si sono invece ancora accordati sulla loro identità etnica: c’è chi sostiene che siano di ceppo turco, chi di ceppo indoeuropeo. La cosa certa è che erano ricchissimi e raffinati e che la loro ricchezza era frutto del florido commercio che fluiva lungo la Via della seta.
Tra le cinque sepolture femminili – solo una fra le sei era maschile – vi è la tomba di una giovane principessa. Sul petto porta un’applique raffigurante una dea seminuda con i fianchi avvolti in un mantello drappeggiato – e quindi il riferimento è a una Venere ellenistica – il segno indiano delle donne sposate sulla fronte, e le ali. Nessuna Venere nella cultura classica ha le ali, ci sono però, nella cultura afghana pre-islamica, delle dee con le ali.
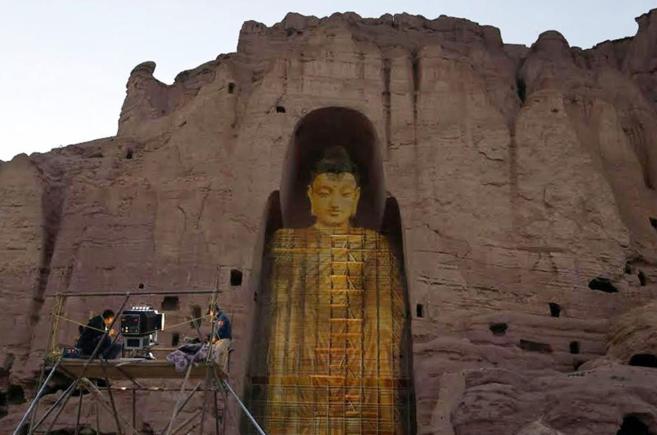
Una ricchezza storica e culturale che si innesta in una società ancora fortemente tradizionale e arcaica, ben tratteggiata nel saggio nei suoi aspetti principali.
Il pashtunwali, innanzitutto, il codice tradizionale non scritto e dal carattere sostanzialmente laico dell’etnia maggioritaria dei pashtun. I suoi fondamenti sono l’ospitalità, la vendetta, l’obbligo di sottomissione al vincitore, il perdono quando richiesto dall’avversario, l’indipendenza,
la giustizia. Il nang e il namus, l’onore e l’orgoglio di un pashtun, dipendono essenzialmente dal comportamento delle donne della famiglia sulle quali il capofamiglia ha il dominio assoluto, dalle quali fa dipendere il proprio buon nome e alle quali impone una condotta di semiclausura. La trasgressione di una donna è pagata con il disonore dell’intera famiglia, un castigo peggiore della morte.
L’etnia maggioritaria dei pashtun detiene, storicamente, il potere politico – Hamid Karzai è infatti un pashtun, come evidenzia il chapan nel quale è sempre avvolto, il lungo mantello, spesso a righe colorate, il grande turbante o il berretto di astrakan in testa.
L’etnia hazara porta il peso del disprezzo generale, ed è considerata inferiore ‘per natura’. “Gli uzbeki in Uzbekistan, i tagiki in Tagikistan e gli hazara nel goristan” recita un detto popolare. Il goristan è il cimitero. A questo si aggiunge la diversità religiosa: i pashtun sono mussulmani sunniti, gli hazara sono sciiti. La maggior parte è analfabeta, a Kabul vive in quartieri ghetto dove non ci sono né elettricità né acqua potabile e fa lavori che nessun altro è disposto a fare. A tirare i carretti per strada per trasportare materiali da costruzione, derrate alimentari, qualunque cosa, al posto dell’asino c’è ancora un hazara.
Bicchiere con decoro dipinto (ganimede).
Ci sono poi i nomadi khoci – il suolo afghano è ancora oggi percorso da oltre due milioni di nomadi, non solo khoci – che disprezzano i sedentari – un disprezzo ricambiato – e che, privi di qualsiasi documento, non sono ‘controllabili’ in alcun modo. Le loro carovane si spostano anche di 1.500 chilometri, incuranti delle frontiere, per raggiungere i pascoli; “Che tu possa non essere stanco” è il saluto che si scambiano.
La regione a nord dell’Hindu Kush, con il Badakhshan e il Palmir, è la terra di origine dei tagiki: i tratti somatici forti, il shalwar-kamiz – larghi pantaloni e camicia lunga al ginocchio – il copricapo pakol, la barba corta e la parlata farsi contraddistinguono a colpo d’occhio un tagiko. Si riconoscono nella cultura persiana, non sono associati in tribù e non hanno un rigido modello di comportamento codificato dalla tradizione.
La loro ‘identità’ è considerata debole: si dice che sia tagiko chi non è né pashtun, né uzbeko, né turcomanno, né hazara.
 Grande moschea di Herat
Grande moschea di Herat












Commenti
Posta un commento